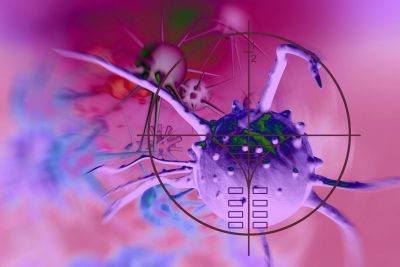Tradizionalmente, si riteneva che le alterazioni epigenetiche derivassero principalmente da processi interni alla cellula, come l’etichettatura chimica del DNA e delle proteine istoniche associate, inclusi meccanismi come la metilazione degli istoni o l’acetilazione del DNA. Tuttavia, un nuovo studio condotto da Richard White del Ludwig Oxford e Miranda Hunter del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, pubblicato su Nature, rivela che anche le condizioni fisiche che circondano le cellule tumorali sono potenti fattori scatenanti del cambiamento epigenetico.
Stress meccanico e HMGB2
Lavorando su un modello di melanoma in un pesce zebra, White, Hunter e i loro collaboratori hanno scoperto che le cellule tumorali sottoposte a stretto confinamento fisico subiscono drastici cambiamenti strutturali e funzionali. Invece di moltiplicarsi rapidamente, queste cellule adottano un programma di “invasione neuronale”, che le rende in grado di migrare e infiltrarsi nei tessuti circostanti.
Al centro di questa trasformazione c’è HMGB2, una proteina che piega il DNA. Lo studio dimostra che HMGB2i risponde allo stress meccanico indotto dal confinamento legandosi alla cromatina, rmodellando il modo in cui il materiale genetico viene impacchettato. Questa riorganizzazione espone regioni del genoma legate al comportamento invasivo, rendendole disponibili per l’espressione. Di conseguenza, le cellule con livelli elevati di HMGB2 perdono parte della loro capacità proliferativa, ma diventano più invasive e resistenti alla terapia.
Ristrutturazione sotto pressione
Il team ha anche scoperto che le cellule di melanoma si adattano a questa pressione esterna rimodellando il loro scheletro interno, formando una struttura a gabbia attorno al nucleo. Questo scudo protettivo coinvolge il complesso LINC, un ponte molecolare che collega lo scheletro cellulare all’involucro nucleare, contribuendo a proteggere il nucleo dalla rottura e dai danni al DNA causati dallo stress indotto dal confinamento.
“Le cellule tumorali possono passare rapidamente da uno stato all’altro, a seconda degli stimoli ambientali”, ha spiegato White. “Il nostro studio ha dimostrato che questo passaggio può essere innescato da forze meccaniche presenti nel microambiente tumorale. Questa flessibilità rappresenta una sfida importante per il trattamento, poiché le terapie mirate alle cellule in rapida divisione potrebbero non rilevare quelle che sono passate a un fenotipo invasivo e farmacoresistente. Identificando i fattori coinvolti in questo passaggio, speriamo di poter sviluppare terapie che prevengano o addirittura invertano la trasformazione invasiva“.
Leggi anche:Lo stress causa la calcificazione dei vasi sanguigni ?
Spiegano gli autori:
“È ormai ben noto che la capacità delle cellule tumorali di adottare nuovi fenotipi senza ulteriori mutazioni del DNA influenza sostanzialmente il comportamento del tumore. Tale plasticità è stata osservata a lungo nel melanoma, dove studi iniziali hanno identificato stati trascrittomici e fenotipici non legati a specifiche lesioni genetiche. Prove più recenti indicano che la maggior parte dei tumori comprende un numero eterogeneo ma riproducibile di stati trascrizionali. La misura in cui le cellule tumorali transitano tra gli stati è un’area di indagine aperta e si ipotizza che sia regolata da segnali provenienti dal microambiente tumorale (TME). L’identificazione di tali segnali ha rilevanza clinica perché può consentire la conversione di un melanoma superficiale in uno invasivo e farmacoresistente. In questo studio, utilizzando una combinazione di cellule transgeniche di zebrafish e campioni umani, dimostriamo che il confinamento meccanico da parte del microambiente adiacente induce cambiamenti stabili nell’architettura della cromatina che causano la transizione delle cellule di melanoma da uno stato proliferativo a uno invasivo”.
I risultati evidenziano il ruolo del microambiente tumorale nel modellare il comportamento delle cellule cancerose, mostrando come segnali fisici possano spingere le cellule a riorganizzare il loro citoscheletro, il nucleo e l’architettura del loro impacchettamento genomico per passare da uno stato di crescita a uno di invasione.
Ma la cosa più notevole è che lo studio dimostra anche come lo stress fisico possa agire come un potente, e sottovalutato, motore del cambiamento epigenetico.
Fonte: Nature